Pubblicata la newsletter Leather Update #1/21
Approfondimenti sulle attività di ricerca, formazione e ogni altra notizia rilevante per la filiera pelle.
Buona lettura!

Pubblicata la newsletter Leather Update #1/21
Approfondimenti sulle attività di ricerca, formazione e ogni altra notizia rilevante per la filiera pelle.
Buona lettura!

di Luigi Nicolais
Il “Decreto Pelle” approvato recentemente rappresenta un notevole passo avanti nell’ambito della valorizzazione dei prodotti made in Italy e nella tutela dei consumatori.
Una tutela che comincia dalla semantica, definendo senza ambiguità le parole “pelli”, “cuoio”, “pelliccia” nell’industria conciaria e impedendo un uso promiscuo di tali parole per identificare prodotti sintetici (ecopelle, similpelle, vegan leather).
Etichettatura, responsabilità delle informazioni riportate in etichetta, contrassegno di garanzia e l’obbligo di dichiarare i materiali, sono le altre novità apportate dal decreto.
La lotta all’imitazione fraudolenta si combatte con l’informazione ma anche e soprattutto con le leggi che regolamentano e all’occorrenza sanzionano. Se da un lato il consumatore deve essere pienamente consapevole di ciò che acquista attraverso una indicazione chiara ed univoca dei materiali utilizzati, dall’altro le norme e le autorità preposte devono svolgere azioni di controllo e azioni sanzionatorie nei confronti di chi commette una frode.
La legge è uno strumento indispensabile in tutta la filiera della pelle, che non solo tutela il consumatore garantendo qualità e sicurezza dei prodotti acquistati ma difende anche il settore produttivo di riferimento da azioni scorrette provenienti soprattutto da imprese di Paesi esteri, sostenendo le aziende che operano nella legalità e che soffrono l’erosione di una notevole quota di mercato a favore della concorrenza sleale.
ll comparto della pelletteria è uno dei settori dove la creatività italiana è più apprezzata ma anche quella più colpita dalla contraffazione, circa un terzo del fatturato annuo del settore, infatti, è destinato al falso.
Il Decreto oggetto di questa riflessione ha anche un altro merito: quello di aver affidato mediante una Legge dello Stato una funzione pubblica delicata alla Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti (SSIP) nella lotta alla contraffazione.
Gli organi di accertamento possono avvalersi delle indiscusse competenze e della comprovata esperienza della Stazione Sperimentale per verificare che i requisiti di qualità del prodotto conciario siano tali da meritare l’etichetta made in Italy e che possano essere immessi sul mercato senza che sia compiuto nessun illecito.
Il ruolo della SSIP, eccellenza nel campo della ricerca, è dunque quello di verificare la conformità dei manufatti, le specifiche tecniche e accertare le eventuali violazioni o inadempienze.
La contraffazione non è solo un fenomeno che impatta sull’economia di un settore ma rappresenta un disincentivo all’innovazione, costituisce un “moltiplicatore” di illegalità che genera una pluralità di condotte illecite (lavoro nero, riciclaggio, evasione fiscale) e come tale va contrastata con gli strumenti adeguati. Il “Decreto Pelli” insieme con la SSIP pone le basi per una lotta seria alla frode nel settore conciario, tutela il consumatore e garantisce la qualità dei prodotti di pregio.
Editoriale di CPMC Magazine CPMC – Volume XCVI – Anno 2020 – 02/03 [Maggio/Dicembre]. Per leggere la rivista di SSIP clicca qui!

Marco Nogarole Responsabile del Trasferimento Tecnologico verso le Imprese e dell’Ufficio presso il Distretto di Arzignano, è un chimico formulatore. Professionista eclettico e dalle riconosciute competenze.
Ha una laurea in Chimica Magistrale, conseguita presso l’Università degli studi di Padova, ed una grande passione per l’informatica e per tutto quello che esplora il nuovo.
Quale il ruolo del Trasferimento Tecnologico?
Il compito del Trasferimento Tecnologico è quello di sfruttare le conoscenze della ricerca per creare nuovi prodotti, processi, applicazioni, materiali o servizi e individuare le tecnologie che hanno un potenziale interesse commerciale.
In un certo senso il TT mette trasmette al settore produttivo l’efficacia della R&S, la quale dovrebbe basarsi sugli indicatori più comuni come il fatturato o numero e valore commesse, nel numero di brevetti e sui giudizi nelle recensioni delle pubblicazioni scientifiche
Per quanto riguarda il punto di vista del TT è, perciò, determinante cercare di soddisfare il fabbisogno delle aziende del nostro settore (concerie, prodotti chimici e utilizzatori del cuoio, aziende per trattamento degli scarti, reflui e rifiuti, costruttori di macchinari e di controllo).
Su quali direttrici?
Il primo interrogativo che il TT si pone è la stessa che si pongono gli operatori di imprese del settore: quali sono le innovazioni utili all’azienda per aumentare il valore competitivo dei prodotti, migliorare le performance, ridurre gli sprechi, avere maggior controllo delle operazioni.
Perciò, l’impulso alla ricerca viene spesso alimentato dalle aziende.
Non sempre però le imprese riescono a concretizzare una richiesta o una necessità di innovazione precisa. Lo studio dei fabbisogni in questo caso non è sufficiente. Sovente le intuizioni provengono dai ricercatori che intravedono un possibile beneficio in una ricerca. Il compito del TT in questo caso e di riuscire a tradurla ed in grado di esporne la sua utilità nel modo più efficace al mondo produttivo.
Se non si soddisfano queste condizioni: richiesta precisa di una soluzione o una nuova chiara tecnologia utilizzabile il progetto rischia di fallire e di non interessare alle aziende.
Considerazioni sulla Sostenibilità nel nostro settore. Cosa cambia e come
Sotto l’aspetto della sostenibilità il prodotto cuoio sappiamo avere un impatto ambientale favorevole rispetto ad un materiale plastico da risorse non rinnovabili. Oltre al valore aggiunto merceologico della pelle come il maggior confort, la traspirabilità e l’appeal, ma soprattutto la maggior durabilità a cui consegue una vita più lunga e perciò un minor impatto ambientale.
Se il vero punto debole della sostenibilità ambientale rimane l’allevamento, una parte che non riguarda la produzione della pelle conciata ma che da esso attinge le materie prime, e pur vero che, il consumo d’acqua e l’inquinamento chimico sono campanelli d’allarmi che risuonano spesso.
Le parole d’ordine sono: usare processi che impiegano meno acqua e che utilizzano prodotti chimici non pericolosi e da fonti rinnovabili.
A livello globale è la risorsa idrica ad aver la priorità su tutto il resto. Nonostante le aziende produttrici e le grandi firme utilizzatrici di pellami hanno indirizzato le loro attenzioni su conce alternative esenti da cromo o formaldeide ed altri processi eco-compatibili, è sull’acqua che si gioca la partita più importante.
Da sempre allora ed in questo momento particolare ?
La contingenza pandemica ha aperto nuove difficoltà e per il cuoio si potrebbero realizzare delle opportunità in quanto per molto tempo ancora il mantra sarà “sanificare” e “sicurezza biologica”. Quali materiali si presteranno con maggior successo a soddisfare criteri di superfici sicure sotto l’aspetto sanitario? Non solo verso virus, ma su tutti i microorganismi patogeni. Gli istituiti di ricerca e le aziende sono avidamente al lavoro e la corsa è appena cominciata; il risultato non è scontato ma la pelle, opportunamente rifinita può avere molte possibilità.

Vigonza, 21 dicembre 2020 – La ricerca sulla filiera della pelle nel settore calzaturiero riceve nuovo impulso.
Il Presidente del Politecnico Calzaturiero della Riviera del Brenta Franco Ballin e il Direttore della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) Edoardo Imperiale
Sono stati recentemente pubblicati (nell’ottobre del 2020), due nuovi metodi per la determinazione di alcuni dei preservanti più utilizzati in ambito conciario; i nuovi standard sono: UNI EN ISO 13365-1 e UNI EN ISO 13365-2, ed entrambi utilizzano la cromatografia liquida come strumentazione di rivelazione

Pubblicata la newsletter Leather Update #37
Approfondimenti sulle attività di ricerca, formazione e ogni altra notizia rilevante per la filiera pelle.
Buona lettura!

Pubblicata la newsletter Leather Update #37
Approfondimenti sulle attività di ricerca, formazione e ogni altra notizia rilevante per la filiera pelle.
Buona lettura!

Tiziana Gambicorti è il coordinatore del Dipartimento di Ricerca sulle Tecnologie di Processo della SSIP, oltre che responsabile della sezione di S. Croce sull’Arno e dell’Ufficio Normazione. La laurea in chimica pura, conseguita all’ Università di Pisa con 107/110 e la lunga esperienza

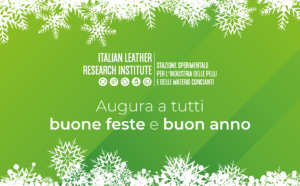

Al via i controlli sui manufatti in «cuoio», «pelle» e «pelliccia», la nuova funzione pubblica della Stazione Sperimentale per la tutela del Made in Italy ed al servizio delle imprese
Si è avviato il Progetto Settoriale di Vigilanza sui prodotti del comparto moda,
+++ Si comunica che alcune funzioni del sito potrebbero non risultare aggiornate poiché il sito è in manutenzione +++