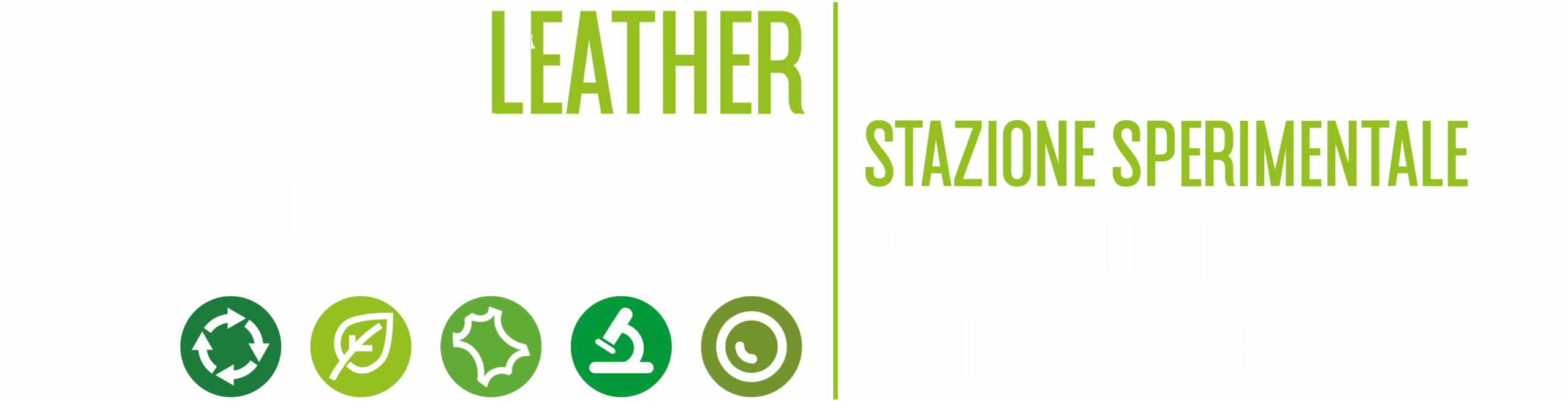6 Dicembre 2021
Liquefazione idrotermale: un processo emergente
Liquefazione idrotermale: un processo emergente per l’ottenimento di bio-liquidi di interesse energetico da fanghi di…

1 Aprile 2021
Liquefazione Idrotermale (HTL) di Fanghi Conciari
Il 14 e 15 aprile 2021 si terrà il 10° European Combustion Meeting, in virtual…