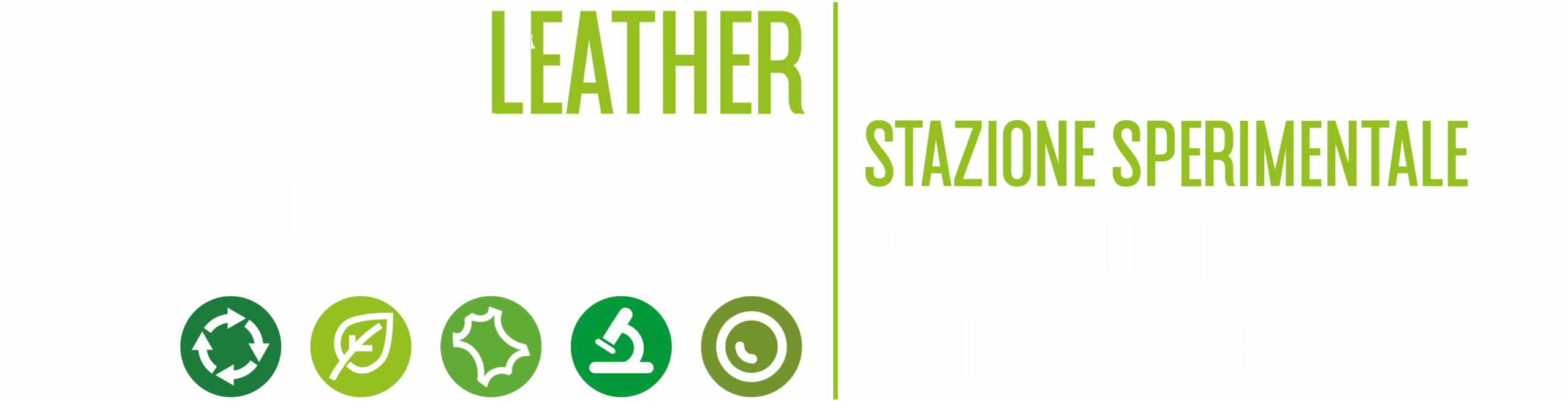Jun 18 2025
/
Da CPMC – Tamburini (Pres. Camera Commercio Toscana Nord-Ovest): “Il cambio di paradigma dovrà essere una conquista effettiva”
Il paradigma della produzione conciaria si deve necessariamente spostare, abbracciando la valorizzazione della conoscenza “immateriale” e non solo materiale dei prodotti: quanto, secondo lei, gli operatori sono pronti ad un cambio di direzione del genere? La crescente attenzione ai temi della sostenibilità, responsabilità sociale, innovazione in una competizione globale sempre più accesa ha innescato un processo di profonda trasformazione che sta attraversando molti settori industriali, quello conciario incluso. Dare valore alla conoscenza “immateriale” del prodotto conciario e dunque al compendio di competenze artigianali, know-how tecnico, tradizioni e tecniche che sono essenziali per ottenere un prodotto conciato di alta qualità, rappresenta una svolta che obbliga ad allargare visione e attenzione ben oltre il prodotto materiale e le sue esclusive peculiarità fisiche e tangibili. Come è noto lo scenario imprenditoriale italiano è caratterizzato dalla prevalenza nettissima di PMI (il 99% delle imprese esistenti) attive in settori tradizionali che spesso frena la capacità d’innovazione in genere. Pertanto l’affermazione di un paradigma che valorizzi la conoscenza immateriale del prodotto conciario, pur essendo a mio avviso già in corso, dovrà diventare una conquista effettiva e non sarà priva di elementi fortemente sfidanti per imprese ed istituzioni. Non so dire se e quanto siano pronti gli imprenditori di settore ad un cambiamento che impone in primo luogo una vera e propria rivoluzione culturale che deve vincere la tendenza alla conservazione in un processo produttivo, come quello conciario, fondato su tecniche consolidate, che deve superare il timore di costi aggiuntivi non sostenibili in un contesto di crisi. Ed inoltre la disponibilità degli operatori a cambiare non è una loro esclusiva responsabilità, non dipende soltanto dalla loro capacità di individuare i vantaggi di questa trasformazione, ma anche dalla prevedibile pressione del mercato se i consumatori saranno sensibilizzati adeguatamente al valore dell’autenticità, della sostenibilità, dell’innovazione, delle pratiche etiche. E servirà infine supporto tecnico, formativo, normativo, finanziario. La ricerca a supporto sempre della produzione ma in che senso, secondo lei, può intervenire per sollecitare una visione sempre più green del sistema? Il non sempre proficuo rapporto tra ricerca e produzione è tema ricorrente che peraltro risente anche della complessità sopraggiunta in tutti i comparti produttivi per la transizione digitale, green, etica che li attraversa e che ampliano la necessità di un approccio scientifico olistico, integrato e multisettoriale. Per il settore conciario, afflitto storicamente dalla sua associazione a pratiche inquinanti per essere industria fortemente chimica e consumatrice di risorse naturali, la ricerca è cruciale nel mitigare sensibilmente l’impatto ambientale intervenendo in ogni segmento del processo produttivo e gestionale ottimizzandoli. La ricerca, tuttavia, per incidere complessivamente nel sistema, deve andare oltre l’intervento sui processi produttivi rivolgendosi anche agli aspetti formativi ed educativi in materia di in sostenibilità e innovazione ambientale. Formazione per gli addetti ma anche educazione dei consumatori, un vero e proprio marketing verde che orienti il mercato verso la domanda di prodotti eco-friendly e sostenibili di cui siano resi diffusamente noti i benefici. Dal passato al futuro, non più con un “Made in”, ma con un “Will make in”, in una visione più fattiva del settore: può essere questa una strada da percorrere? E il supporto di istituzioni quanto è importante in questo caso? È indubbio quanto il “Made in” abbia avuto e continui ad avere un ineguagliato valore identitario e distintivo, rimarcando la qualità, la creatività e il genio italiano universalmente riconosciuti. A conferma di questo basti citare la perdurante attività di contraffazione di prodotti italiani a varie latitudini e la necessità di adeguare continuamente il sistema complessivamente inteso a tutela delle nostre produzioni. La situazione attuale, tuttavia, connotata da globalizzazione e radicali cambiamenti socio economici legittima a considerare la sola etichetta di origine una visione da raffinare in termini più dinamici e proiettati nel futuro. Si sta affermando soprattutto nelle nuove generazioni un crescente interesse a ciò che sta dietro alla mera provenienza di un prodotto e dunque il “Will make in” mette più adeguatamente in risalto il futuro in termini di conseguenze ambientali ed impatti sociali, pone nuove domande di trasparenza e responsabilità etica. In questo nuovo contesto così diversificato diventano protagonisti innovazione, sostenibilità, digitalizzazione, intelligenza artificiale, automazione, tracciabilità, etica, responsabilità sociale, tutti ambiti in cui le istituzioni hanno compiti, competenze e doveri chiari in termini di opzione politica, gestione amministrativa, individuazione di priorità e destinazione di risorse finanziarie e di regolamentazione. Il supporto delle istituzioni in questa transizione dal passato al futuro su larga scala è quindi da ritenersi cruciale e la strada del “Will make in” una necessità anche per un futuro più rassicurante nel settore conciario.
Related Posts

Delegazione del Sudafrica visita il Distretto della Pelle
Nei giorni scorsi il distretto della pelle della nostra provincia ha ricevuto la visita di…

XXXIII Congresso IULTCS 2015
ABQTIC is the association currently in charge of the organisation of the XXXIII IULTCS CONGRESS…

World Leather Congress 2015
MILAN, The Capital Of Leather "Trends and Future Challenges" is the subject of the 2nd…

Ricerca
Le attività di Ricerca della SSIP sono rivolte essenzialmente alla Chimica e Tecnologia Conciaria, nonché…