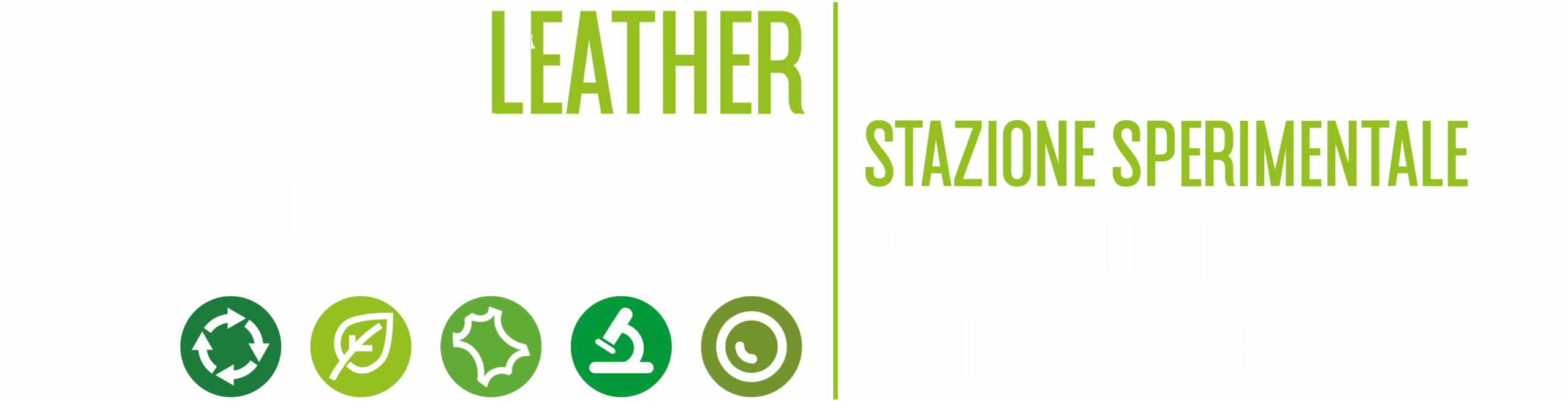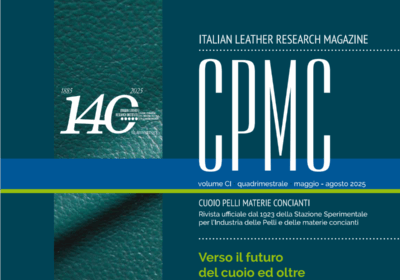
DA CPMC – AA VV “Anticipare la sostenibilità nel manifatturiero: sinergie e risultati della survey Solaris – ReStart”
Tra i progetti afferenti alle attività del partenariato esteso PNRR MICS – Made in Italy…

FOCUS SCIENTIFICO – Le sostanze grasse nella pelle e nel cuoio
Le sostanze grasse sono componenti naturali della pelle e svolgono un ruolo cruciale nel determinarne…
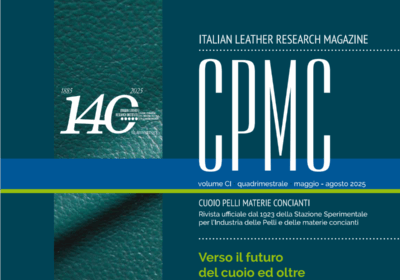
DA CPMC – GIANNOCCARO: “Modelli di Business Innovation e Supply Chain Circolari per un nuovo Made in Italy”
Il progetto MICS – “Made in Italy Circolare e Sostenibile” – è un partenariato esteso…
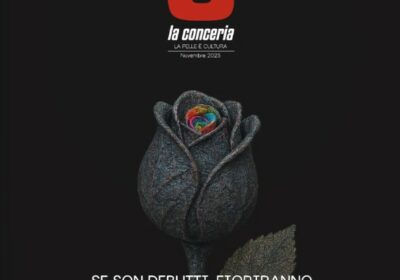
RIVISTA – LA CONCERIA NOVEMBRE 2025
◊ Letture presso la Biblioteca della Stazione Sperimentale Pelli ◊ Rivista di settore: La Conceria – Attualità e…

LEATHER UPDATE N. 45/2025
Pubblicata la nostra Leather Update con notizie, focus scientifici e curiosità dal mondo della pelle…

MAGAZINE – CTC Entreprises ott.-nov. 2025
◊ Letture presso la Biblioteca della Stazione Sperimentale Pelli ◊ Rivista di settore: CTC entreprises Questa rivista,…

FORMAZIONE – Conclusa la I parte del progetto “FREE MEETINGS FOR STEM ENTHUSIASTS”, tra ITTE Galilei e SSIP
Conclusa la prima parte del progetto per il riconoscimento PCTO denominato "FREE MEETINGS FOR STEM…

ASSEMBLEA UNPAC – Imperiale (SSIP): “Fondamentale la formazione di settore a più livelli”
Si è tenuta ieri ad Arzignano, presso il Distretto Veneto della Pelle, l'annuale assemblea UNPAC.…
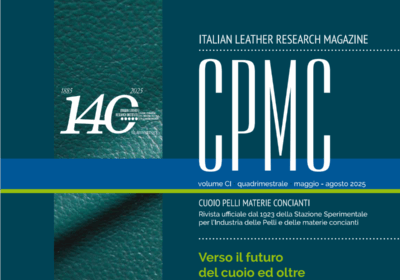
DA CPMC – FLORIO (Resp. area Ricerca e Sviluppo SSIP): “Il percorso evolutivo del cuoio nell’universo multidimensionale della sostenibilità della produzione”
Considerate le antichissime origini della produzione conciaria e la sua diffusione globale fin dai tempi…

WORKSHOP SSIP – A OrientaSud workshop con le creazioni in pelle degli studenti di Mia Academy ITS Moda Campania
La Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli ad OrientaSud con la Fondazione Mia Academy ITS…