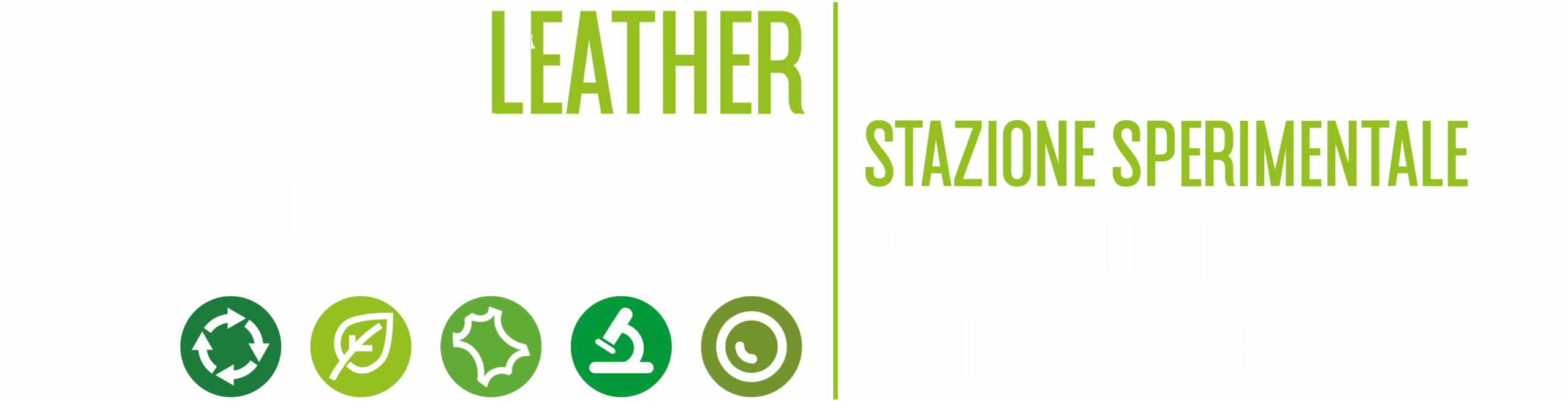Jun 18 2024
/
Nuovi materiali circolari con proprietà aggiunte, nel segno della Simbiosi Industriale
Nuovi materiali circolari con proprietà aggiunte, nel segno della Simbiosi Industriale
A cura di Nicoletta Ravasio, Coordinatrice CTS cluster SPRING
Apparso su CPMC 1/2024
Il percorso verso la decarbonizzazione è lungo e pieno di ostacoli sia tecnici che normativi, ma certamente non può prescindere dall’adozione dei principi di economia circolare. Passare infatti da un modello nel quale i residui e gli scarti di produzione vengono gettati ad uno nel quale ogni residuo e scarto viene riciclato, riusato e meglio ancora valorizzato contribuisce a diminuire la pressione sulle risorse naturali, ridurre la produzione di rifiuti e creare nuovi posti di lavoro (Ref. 1).
In questo contesto la valorizzazione degli scarti della filiera del cibo, sia i residui in campo che gli scarti della produzione e quelli post consumo, gioca un ruolo di primo piano. Infatti non solo questi materiali sono ricchi di composti potenzialmente utilizzabili sia nel settore agricolo che in altri settori industriali, ma spesso essi costituiscono una minaccia per l’ambiente e la salute dei cittadini. Si pensi all’abbruciamento dei residui colturali: non solo questa pratica è da abbandonare per motivi agronomiche (si distrugge sostanza organica, elemento alla base della fertilità del suolo), ma soprattutto essa produce particolato fine, molto nocivo per la salute dei cittadini. Il caso più eclatante è quello della paglia di riso. La combustione della paglia in campo produce 23 kg di PM10 per ettaro, oltre a VOC, NOx ed SOx e naturalmente CO. La pratica alternativa di reinterrare la paglia in risaia provoca, dopo l’allagamento della stessa per il ciclo successivo, la fermentazione in condizioni anaerobiche della paglia stessa con produzione significativa di gas metano, il cui effetto come gas clima alterante è
peggiore di quello dell’anidride carbonica. Il primo passo per la valorizzazione è l’identificazione delle classi di composti
presenti nello scarto vegetale, cellulosa quasi sempre, ma anche oli e grassi, proteine, antiossidanti, zuccheri di varia natura. L’individuazione delle molecole e delle loro attività porta alla progettazione di un percorso di up cycling che tiene conto delle funzionalità e delle architetture molecolari, talora molto sofisticate, di questi composti e ne individua eventuali ulteriori funzionalizzazioni e applicazioni anziché bruciare e fermentare tutta la biomassa per produrre energia. In questo modo questi residui e scarti possono diventare materia prima seconda per altri processi, anche di natura completamente diversa. È quella che si chiama Simbiosi Industriale, cioè una strategia per il trasferimento e la condivisione di risorse tra industrie dissimili.
La diffusione e l’adozione di questo approccio consente di ottenere significativi vantaggi dal punto di vista economico e
ambientale, rendendo i sistemi produttivi complessivamente più sostenibili. I prodotti ottenuti da uno scarto della filiera
alimentare non solo sono bio-based ma soprattutto possono avere proprietà superiori a quelle di analoghi derivati da fossili. Alcuni esempi cominciano ad emergere nel panorama industriale italiano. E’ il caso di Lamberti, impresa impegnata nel limitare ed eventualmente eliminare l’uso di risorse in contrasto con i principi di sostenibilità, che ha recentemente annunciato l’introduzione tra i suoi prodotti di un nuovo coating 100% biobased ottenuto a partire dalla cutina estratta dalle buccette di pomodoro e sviluppato insieme alla start up italiana Tomapaint. Questo coating non solo è di origine naturale e valorizza uno scarto della lavorazione del pomodoro da industria (questi scarti in Italia ammontano a 350.000-500.000 tonn/anno), ma mostra anche elevate proprietà barriera, indispensabili perché il passaggio da plastica a carta negli imballaggi per il cibo sia effettivamente realizzabile. Le opportunità offerte al settore conciario sono moltissime e non limitate all’utilizzo dei tannini nella concia vegetale, metodo ormai consolidato. Nei processi di finitura, tradizionalmente basati su polimeri e composti da carbonio fossile, sono stati esaminati biopolimeri come la cellulosa e il chitosano, la prima ottenibile da paglie e moltissimi altri scarti vegetali ed il secondo da gusci di crostacei o esoscheletri di insetti. Anche oli vegetali e grassi animali, eventualmente modificati per aumentarne le proprietà lubrificanti, possono essere utilizzati. Molto promettenti anche lignina e ligninsolfonati, sottoprodotti questi ultimi del processo al solfito per la produzione di polpa di cellulosa, altri estratti antiossidanti, presenti in moltissimi scarti di lavorazione del cibo, ed alcuni disaccaridi presenti in residui della lavorazione dei cereali o della barbabietola o i loro derivati aldeidici, che si sono dimostrati efficaci non solo nella concia ma anche nel migliorare le prestazioni fisiche della pelle e nella protezione del colore dalla luce solare. Come già ricordato molto spesso capita che le sostanze naturali non solo consentano di sostituire un prodotto chimico ma che aggiungano anche altre proprietà. Per esempio, è stato recentemente riportato che dalle bucce di cipolla si può ottenere un colorante naturale per il cuoio che non
richiede l’uso di un mordente metallico, principale inconveniente di altri coloranti naturali. Il cuoio trattato con questo estratto
e tannini nella fase di concia ha rivelato inoltre significative proprietà battericide nei confronti di Escherichia coli e Bacillus subtilis. Le proprietà antibatteriche e antifungine, osservate anche usando il chitosano nella finitura, sono importanti per contrastare la formazione di difetti nella pelle conciata. Deve poi essere ricordato che anche gli scarti di cuoio possono diventare materia prima seconda. La cartiera FAVINI, per esempio, produce la carta REMAKE nella quale il 25% di cellulosa vergine è sostituita appunto da scarti di cuoio e pelletteria insieme al 40% di cellulosa da riciclo. Alcuni elementi di questi
materiali sono ancora visibili nella carta e le conferiscono una consistenza ed un aspetto particolare creando effetti unici al tatto
soprattutto nella versione goffrata. Naturalmente condizione necessaria per la transizione da economia lineare a circolare è un approccio multidisciplinare e multisettoriale che ben si coniuga con quello del cluster nazionale SPRING, ovvero della Bioeconomia Circolare. È proprio il compito del cluster nel quale sono rappresentate tutte quelle realtà che a diverso titolo operano nel settore della bioeconomia e appartenenti a vari settori dall’agricoltura alla chimica verde, dall’energia al Made in Italy ed al trattamento rifiuti, quello di far interagire i diversi attori. I gruppi di lavoro ed il Comitato Tecnico scientifico promuovono i contatti e le collaborazioni tra associati, grandi e piccole medie imprese, università ed enti di ricerca, tra cui la Stazione Sperimentale per l’industria delle Pelli e delle materie concianti, fondazioni ed altri soggetti attivi nel campo del trasferimento tecnologico e della comunicazione ambientale, anche sviluppando nuove progettualità sulla base
dei bisogni segnalati dai soci stessi. Il cluster inoltre ha attivato un tavolo di lavoro anche con 14 regioni italiane al fine di promuovere il confronto con le realtà territoriali (Ref. 2) Il cluster non trascura gli aspetti riguardanti la normativa in continua evoluzione e contribuisce alla redazione del piano strategico nazionale per la bioeconomia avendo sempre come obiettivo la
decarbonizzazione attraverso lo sviluppo di prodotti e materiali biobased e la riduzione della pressione sulle risorse naturali
attraverso l’adozione di modelli di economia circolare e di simbiosi industriale.
Vuoi ricevere la copia di CPMC? Iscriviti QUI per leggere la rivista ufficiale della Stazione Pelli e non perderti i prossimi numeri.

Related Posts

L’innovazione tecnologica e la ricerca scientifica
31◊ Letture presso la Biblioteca della Stazione Sperimentale Pelli ◊ Autore: Professore Luigi Nicolais, Consigliere scientifico…

La dignita’ del lavoro: pilastro del manifatturiero italiano
◊ Letture presso la Biblioteca della Stazione Sperimentale Pelli ◊ Paolo Bastianiello, Presidente Comitato education di Sistema…
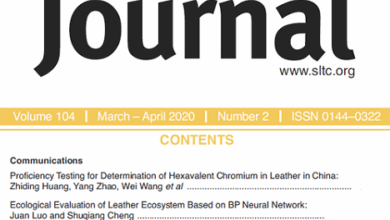
Rivista scientifica SLTC Journal marzo/aprile 2020
◊ Letture presso la Biblioteca della Stazione Sperimentale Pelli ◊ Cerchi informazioni su un termine,…
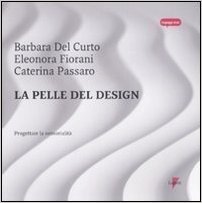
Libro: La pelle del design. Progettare la sensorialità
◊ Letture presso la Biblioteca della Stazione Sperimentale Pelli ◊ Libro: La pelle nel design…